di Marco Palladini
“La maison des souffrances” ► Il 2 novembre del 1943 Camille de Hody, 56 anni, magistrato presso il tribunale amministrativo di Strasburgo, assieme alla moglie Geneviève Utard de Hody e a due domestiche viene arrestato dalla Gestapo a Vieille-Brioude in Alvernia, nell’Alta-Loira. de Hody è un gaullista impegnato nella Resistenza alla occupazione nazista ed è stato denunciato dal proprietario e vicino di casa, Charles Pécoil, imprenditore di pompe funebri e miliziano del regime collaborazionista di Vichy. I coniugi de Hody vengono trasferiti nel carcere militare tedesco del 92° Fanteria a Clermont-Ferrand. Le figlie più grandi, Béatrice e Monique, vengono accudite dalle organizzazioni del ‘maquis’, mentre la minore, Edith, viene affidata ad una famiglia amica del paesino. Da quel momento incomincia la loro odissea detentiva. La moglie Geneviève verrà liberata nel febbraio del 1944, mentre Camille dopo essere stato spostato nel centro di ‘raccolta’ di Compiégne, da lì nel marzo del ’44 verrà destinato al terribile lager di Mauthausen, obbligato ai lavori forzati. Ivi morirà di malattia e di stenti il 12 aprile del 1945 a 58 anni, poche settimane prima che gli americani liberassero il campo.
Tutto questo lo si legge in un libro, La casa del dolore (Passigli Editori, 2023), che contiene uno straordinario ‘memoir’ elaborato da Geneviève Utard de Hody dopo la guerra, scritto innanzitutto per sé e per i suoi familiari, ‘per non dimenticare’, ma poi anche come gesto di memoria civile come lei opportunamente sottolinea: “Ogni cittadino dovrebbe però capire che egli rappresenta, non solo in comunione con gli altri, ma anche individualmente, il suo paese, il suo popolo, la sua etnia… La memoria degli atti di abnegazione e di eroismo compiuti dalle grandi anime si propaga dalla cerchia ristretta dei testimoni diretti. Ma tanto più gli eroi sono stati grandi e nobili nel loro sacrificio, tanto più semplici e discrete sono state le loro azioni, quanto minori saranno le possibilità che siano ricordati e valorizzati, se i privilegiati che hanno visto e anche solo intuito quegli atti non se ne fanno carico”.

E Utard de Hody, testimone diretta e ‘privilegiata’ della tragedia bellica, delle immani sofferenze e dell’eroismo dei resistenti, se ne fa dunque carico attraverso un racconto testimoniale vivido, analitico, di grande efficacia, con uno spirito di osservazione psicologica e fenomenologica di notevole acuzie. Tanto più strano, quindi, che Geneviève non si sia data da fare per pubblicare il libro. Probabilmente gli affanni del dopoguerra, il ritorno a Strasburgo, le nuove responsabilità di capofamiglia, la necessità di mantenere e far studiare le tre figlie, avranno messo questo intento in secondo o terzo piano. Un tale oblio è durato sino alla sua morte avvenuta nell’agosto del 1986 e anche ben dopo. È stato soltanto nel 2011 che il suo ‘memoir’ è stato recuperato dalla figlia Edith, a sua volta sollecitata dalla propria figlia Muriel, molto legata alla nonna, ed è stato finalmente pubblicato in Francia. Edith de Hody che vive dal 1968 in Italia, dopo avere sposato Michele Dzieduszycki, un fiorentino di discendenza polacca, e dove ha realizzato un articolato percorso tra arti visive e poesia, ha impiegato lunghi anni a tradurre La casa del dolore, con l’ausilio e la revisione di Giovanni Marchi, dando così la possibilità anche ai lettori italiani di potere scoprire una narrazione personale che ha la capacità di trasfigurarsi in una narrazione storico-epica, tutta vista dall’interno di una condizione infernale di prigioniera sempre in bilico tra la speranza di essere liberata e il fondato timore di essere trascinata in un cammino senza ritorno verso un campo di concentramento, come poi è accaduto al marito.
Il ‘memoir’ è pieno di dettagli e nitidi ricordi del periodo trascorso nel carcere di Clermont-Ferrand. I prigionieri, quelli rastrellati a caso e quelli denunciati come resistenti e lungamente torturati e quindi fucilati, nonché gli ebrei subito avviati ai campi di sterminio. I rapporti con i secondini militari della Wermacht, quelli che mantenevano un residuo di umanità e quelli più brutali e sadici. Le punizioni, gli imbrogli, le derisioni e gli atti di gratuita cattiveria. Gli agenti della Gestapo, i seviziatori e assassini professionisti della polizia politica nazista che suscitavano terrore e orrore. Lo squallore, le condizioni miserande e la ripetitività della vita dei detenuti, i periodi di prostrazione e depressione, i mille magheggi per avere un po’ più di cibo per sopravvivere, per riuscire a mantenere un minimo di igiene personale, le relazioni difformi, talora anche ambigue, tra uomini e donne, le figure sia maschili che femminili che per status e saldezza intellettuale e psicologica diventavano i punti di riferimento, pressoché i leader della massa dei prigionieri. Quindi, la ricerca spasmodica di notizie e di contatti oltre la bolla repressiva e soffocante della prigione. Le notti insonni, le urla disumane delle persone torturate. I momenti di celebrazione religiosa in occasione del Natale officiati da un cappellano tedesco, poi lui pure arrestato e ucciso dai nazisti. La situazione dei francesi arrestati e quella dei tedeschi prigionieri per i motivi più vari. E poi lo sguardo gettato sui ‘traditori’, i collaborazionisti e delatori già in partenza, i ‘pétainisti’ convinti e quelli che non resistevano alle sevizie e decidevano di diventare informatori dei tedeschi, ed erano i più pericolosi, perché voleva dire che dentro le mura del carcere non ti potevi fidare di nessuno, dovevi stare sempre attento a parlare, chiunque in teoria poteva rivelarsi una spia e denunciarti.
Peraltro, su quest’ultimo argomento, nella sezione documentaria del volume, si riporta un articolo del settimanale “L’Express” del settembre 1989 in cui si osserva: “… sotto l’occupazione la Francia ha battuto i record di delazione. Bilancio: centinaia di migliaia di vittime. E una ferita mai rimarginata… Il colonnello delle SS Bickler, sentito dal tribunale di Norimberga dopo il conflitto, lo ha confermato: «Sulle nostre scrivanie si sono accumulati più di tre milioni di denunce»… Il suo ufficio ha inquadrato i francesi che lavorarono per l’ordine nero: «32.000 agenti», ha precisato… «Senza ausiliari e delatori non si può né rastrellare né tenere occupato un paese»… criminali sono anche le ‘pecore’, gli arrabbiati della lettera anonima. Apertamente o di nascosto, hanno consegnato ogni giorno 2.600 persone ai gendarmi… senza omettere le Kommandatur e la Gestapo. Indicare bersagli ai nazisti equivaleva a un permesso di uccidere”. La Francia occupata come una nazione popolata di ‘corvi’ infami, di vittime ansiose di collaborare con i carnefici.
Tornando al ‘memoir’, si può dire che Utard de Hody abbia quasi steso una relazione prismatica, minuziosa, circostanziata e particolareggiata sul microcosmo carcerario in quell’atroce periodo bellico, mercè una scrittura lineare, comunicativa, ma mai banale, sempre incline al taglio descrittivo sia dell’aspetto fisico e fisiognomico dei tanti soggetti narrati, sia del loro carattere, dei loro comportamenti, delle loro azioni, delle loro doppiezze e debolezze come delle loro fulgide qualità psico-morali.
La casa del dolore è un viaggio di memoria nell’abisso di una guerra di ottant’anni fa, ma è anche un viaggio-monito su determinate invarianti antropologiche di crudeltà, ferocia, viltà e all’opposto di eroismo, integrità e coraggio che valgono pure per il presente e per il futuro. Secondo avrebbe detto Alberto Savinio: “Narrate, uomini, la vostra storia”, in tanti vi si riconosceranno.
Bene monumentale ► In contraddizione con il suo essere stato un inossidabile enfant terrible e gâté del teatro italiano, prosegue a ventuno anni dalla sua morte (marzo 2002) l’opera di monumentalizzazione di Carmelo Bene. La Nave di Teseo ha da poco ripubblicato il tomo Opere, originariamente edito nel 1995 da Bompiani. Già in quel volumone, ordinato e redazionato dal medesimo Carmelo, che aveva voluto raccogliere l’intera sua produzione di testi per la scena e letterari, vi era una prefazione in cui CB asseriva: “Questo libro è il mio monumento da vivo. Il classico è eterno. Ho appena licenziato la mia omnia”. Dunque, il primo a volersi monumentalizzare era proprio lui che si autopercepiva e si auto-offriva come un classico, qualcuno che si eternizzava ancora in vita.
A Lecce, la sua città, intanto, negli ambienti dell’ex Convitto Palmieri è stato inaugurato nel settembre del 2021 l’Archivio ‘Carmelo Bene’, voluto dall’ex moglie Raffaella Baracchi e la figlia Salomè, in cui è stata depositata la sua ingente biblioteca di oltre 4mila e cinquecento volumi, nonché costumi di scena, copioni, sceneggiature, agende fitte di appunti manoscritti, il vasto epistolario, manifesti, locandine e fotografie. Ma ci sono ancora da inventariare ben 117 scatoloni ricolmi di materiali, forse con non pochi inediti, tra cui il poema “Leggenda” di cui aveva parlato l’ultima compagna-assistente di CB, Luisa Viglietti, nel suo libro autobiografico Cominciò che era finita (2020).
Da alcuni mesi è poi arrivato nelle librerie un enorme tomo di 1730 pagine, Si può solo dire nulla (il Saggiatore, 2022), in cui sono state raccolte se non tutte, almeno la stragrande maggioranza delle interviste rilasciate dall’attore-regista salentino. Che, ad onta del sommo disprezzo che aveva per la categoria dei giornalisti, era invero loquacissimo e sempre pronto a parlare con la stampa, anche per diffondere all’universo mondo l’amplissimo suo campionario di strali ed invettive che erano parte integrante, direi costitutiva della sua incessante opera di decostruzione dell’arte sia teatrale sia cinematografica, nonché della cultura in generale. Opera immane a largo spettro, senza la quale nulla si potrebbe intendere della sua poetica e della visione critica che innervava il suo genio di artifex in scena.
I devotissimi filo-carmelitani che si sono assunti l’oneroso compito di curare il tomo delle interviste, sono lo scrittore e illustratore Luca Buoncristiano, che aveva collaborato con la defunta Fondazione L’Immemoriale per catalogare l’eredità di CB, dunque conosceva le carte e aveva già curato una raccolta degli articoli sportivi di Bene; e il filosofo Federico Primosig, grande appassionato dell’autore di Sono apparso alla madonna. I due curatori hanno avuto la felice intuizione di capire che in queste centinaia e centinaia di interviste si rinveniva la voce-corpo di CB, come fosse una colossale messa in scena. Scrive Buoncristiano: “… l’attore come emanatore di straordinarie forze poetiche è un fatto energetico che appartiene al mondo dell’effimero, in quanto nasce e muore ogni sera in scena e ogni sera è unica e irrestituibile…”. Ecco qui l’inimitabile voce-corpo di CB ci viene restituita, moltiplicata e frastornante, come un’esplosione energetica, come un fiume che esonda, come un’alluvione di parole e motti in cui si condensa la summa del Carmelo Bene-pensiero e contropensiero, laddove pur in una prospettiva di forte e complessiva coerenza di postura artistico-intellettuale dagli esordi sino alla fine, le variazioni, le piroette, gli spostamenti, i cambiamenti, il costante dirsi e contraddirsi come movimento polemico in atto, non mancano mai di apparire come l’espressione di un vitalismo irresistibile nel cui gorgo tumultuoso il problema non è realizzare dei capolavori, ma ‘essere un capolavoro’. Ciò che CB indubbiamente è stato.

Il tomo naturalmente per le sue dimensioni non si presta ad essere letto dalla prima all’ultima pagina o anche viceversa. Va, piuttosto, consultato con incursioni e carotaggi trasversali secondo una enciclopedia, un repertorio monumentale, appunto, di quasi quarant’anni che principia con una intervista rilasciata il 7 gennaio 1963 a Ruggiero Guarini (“Il Messaggero”) subito dopo lo scandalo dell’allestimento Cristo’63, interrotto dopo la prima recita con tanto di intervento della polizia che sigillava il Teatro Laboratorio di via di Roma Libera nella capitale; e si conclude con un colloquio, il 12 settembre 2001, con Giancarlo Dotto (“L’Espresso”), giornalista suo amico, in cui CB parla di uno straniato omaggio che intende fare a Elvis Presley nel festival Otranto-Musica di cui era diventato direttore artistico.
Nel tomo ci sono pure io con un resoconto su “Paese Sera” (6 gennaio 1988) di una tempestosa conferenza-stampa al Teatro Quirino di Roma per la presentazione di Hommelette for Hamlet, lavoro invero bellissimo che, se non vado errato, vinse quell’anno il Premio Ubu come miglior spettacolo dell’anno.
Nel tomo, comunque, ‘tout se tient’, in un perpetuo moto circolare tutto si ragguaglia a tutto, il dire nulla o il nulla equivale a dire il nullatutto, un effare in cui la voce-corpo, il linguaggio parlato, l’oralità di CB risulta sempre inconfondibile. Apro a caso il libro: pagina 872, è la lunga intervista concessa a Michele Fumagallo nel febbraio del 1982, ma pubblicata (non si sa perché) soltanto il 18 novembre 2000 sulle pagine di “Alias”, il supplemento culturale di “il manifesto”. CB dixit: “… il linguaggio fonda l’esistenza. Non ci può essere infelicità, se non nella mancanza di linguaggio. La mancanza della poesia è l’infelicità, tutto il resto è una cretinata. Se gli uomini fossero, tramite un partito, tramite l’uguaglianza, tramite non so quale altra conquista sociale del cazzo, se domani fossero felici, si suiciderebbero un minuto dopo, mi spiego? Quindi non è la felicità che cerca l’uomo, ma cerca veramente o l’ascolto religioso, Heidegger direbbe l’indicibile, o il linguaggio, cioè l’esistenza, ma l’esistenza non è data dalla famiglia, non è data dal conto in banca, non è data da case da ricostruire nemmeno… Io non faccio spettacolo, fondo l’esistenza. Cosa vuole dire tradotto nei versi? Non è un modo particolare di dire i versi, è un modo di fondare il verso. Non c’è referente. L’attore, in genere, e chiunque di noi dice dei versi, dice Dante supponiamo, non fonda un bel nulla, propone un referente a un linguaggio scritto: da qui non scatta commozione alcuna nei confronti diciamo delle platee. Per forza non scatta, perché ha un referente nel linguaggio scritto. A questo punto il linguaggio della carta, che fondava già un’esistenza, al momento che è detto, è riferito, è linguaggio morto, ecco. Io taglio ogni referenza possibile col Dante scritto. Il Dante che dico è mio nel senso che non appartiene nemmeno più a me, è linguaggio che fonda l’esistenza in quel momento. La lezione di un grande poeta, affronterò prestissimo Leopardi e Hölderlin, è anticivile”.
Come si può comprendere, CB lo puoi pure monumentalizzare, ma non potrai mai normalizzarlo. Un classico, sì, ma eterodosso ed eteropensante da sempre e per sempre.
“La rabbia” ►A proposito di CB mi fa piacere segnalare la prossima pubblicazione della tesi di dottorato di una giovane studiosa nonché attrice lombarda, Silvia Gussoni. Il saggio intitolato Non esisto: dunque sono (fulminante citazione beniana ripresa da La voce di Narciso, 1982), è incentrato sulla rilettura critica e la pubblicazione di due copioni inediti di CB: Faust o Margherita (1965-1966) scritto con Franco Cuomo e Romeo & Giulietta (storia di Shakespeare) secondo Carmelo Bene, (1976-1977), di cui figurano come collaboratori ancora Cuomo e Roberto Lerici, altro storico dramaturg del primo CB.
Di Silvia Gussoni ho, peraltro, visto tempo fa a Roma, per una rassegna curata dal collettivo Zeugma, un suo allestimento La rabbia (di Pier Paolo Pasolini), di cui è interprete, regista e drammaturga. Un bel lavoro basato sull’adattamento della sceneggiatura del docu-film del 1963, con alcune interpolazioni testuali, anche, da Comizi d’amore.

La cosa, forse non tanto sorprendente, è l’attualità delle parole di PPP dopo esattamente sessant’anni, è constatare come l’acuzie del suo sguardo, la forza del suo pensiero critico risuonino ancora al presente come un preciso monito verso tutte le irrisolte contraddizioni etiche, sociali, economiche, politiche del sistema che proprio in quel preciso momento storico stava dando luogo ad un neocapitalismo delle merci e del consumismo che il poeta friulano bollò come il nuovo fascismo capace in Italia, al contrario del vecchio fascismo mussoliniano, di stravolgere i fondamenti tradizionali della società e di avviare una mutazione antropologica irreversibile. L’interpretazione di Gussoni si è declinata in un assolo d’attrice di bella energia e intensità, accompagnato da immagini, suoni, voci registrate e con una coreografia pure di gesti e movimenti in piedi e a terra di poetica ispirazione. Implementata dal fatto che gli spettatori erano disposti di spalle ai lati di un corridoio scenico centrale, ciò che costringeva gli astanti a sbirciare, torcendo il collo ora a destra ora a sinistra, il percorso di Gussoni. Che ad un certo punto ha indossato un abito lungo rosso fiammante che mi ha ricordato un famoso pezzo del gruppo rock CSI, Irata, in cui Giovanni Lindo Ferretti cantava: “Oggi è domenica, domani si muore / Oggi mi vesto di seta e candore / Oggi è domenica, domani si muore / Oggi mi vesto di rosso e d’amore”. Il medesimo brano proseguiva, poi, con la citazione precipua di alcuni icastici versi di Pasolini: “Ad onta di ogni strenua decisione o voto contrario / Mi trovo imbarazzato, sorpreso, ferito / Per un’irata sensazione di peggioramento / Di cui non so parlare né so fare domande”.
Vestita di rosso, di rabbia e d’amore Gussoni ci comunica, appunto, una trans-epocale “irata sensazione di peggioramento”, che nessuno di noi riesce ‘veramente’ oggi a mettere a fuoco, né ad interrogare utilmente. Sappiamo soltanto che “domani si muore”.
“Gaddabolario” ► Lo scorso maggio (il 21 per la precisione) cadeva il cinquantenario della morte di Carlo Emilio Gadda (1893-1973). Pochissimi se lo sono ricordato, sui media la data è per lo più passata in cavalleria. Non me ne stupisco. La grandezza della scrittura di Gadda, il suo inarrivabile, ricchissimo barocchismo linguistico sono irricevibili in un’epoca dominata dallo story-telling più sciatto e corrivo. Gadda è, forse, stato il più grande prosatore in lingua italiana dopo Boccaccio, ma sospetto che i più giovani, oggi, non soltanto non lo leggono, ma non sappiano neppure chi è.
In questo panorama di desolante smemoria su “l’Ingegnere in blu” (Alberto Arbasino dixit), voglio comunque salutare l’uscita di uno sfiziosissimo libro con un titolo opportunamente neologistico: Gaddabolario (Carocci editore, 2022), curato dalla studiosa Paola Italia che, con Giorgio Pinotti e Claudio Vela, si sta occupando della riedizione, presso l’editore Adelphi, delle opere del Gran Lombardo. Questa sorta di vocabolario attinente a 219 parole estratte dalla immensa officina letteraria gaddiana – le parole, volendo, avrebbero potuto essere centinaia o migliaia di più – reca una introduzione in cui la filologa Italia così presenta il volume: «Se avete in mano questo libro vuol dire che appartenete a una delle due seguenti categorie. O siete tra quelli che Carlo Emilio Gadda non lo hanno mai letto, lo hanno sentito nominare come “l’Ingegnere della letteratura”, “il Joyce italiano”, “il giocoliere delle parole”, ma finora si sono tenuti a distanza di sicurezza… Oppure siete, come me e gli altri più di sessanta collaboratori di questa impresa, della categoria degli “adepti”, cioè di coloro che hanno incontrato in un dato momento della loro vita un libro di Gadda… e dopo il primo smarrimento… hanno deciso che non lo avrebbero lasciato più, che quella prosa era diversa da qualsiasi altra, che il piacere della sua lettura era imparagonabile al piacere di ogni altra lettura…».
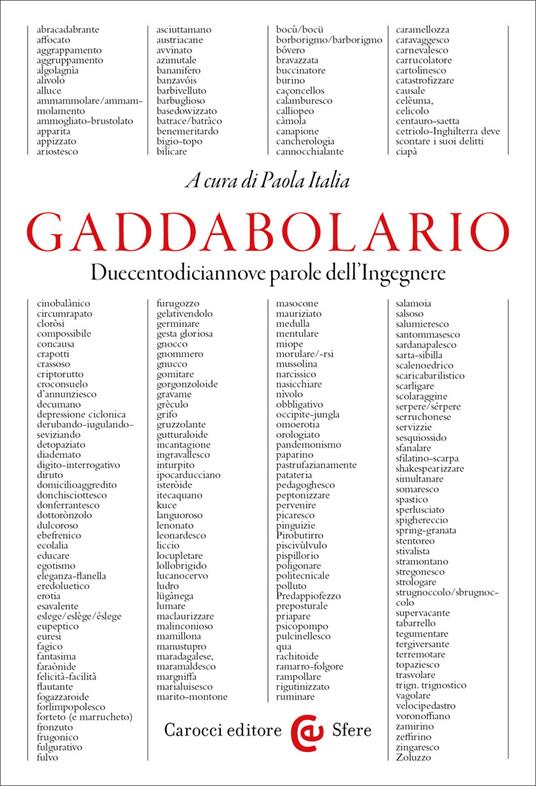
Ecco, essendo personalmente un ‘adepto’ gaddiano dalla fine degli anni ’70, questo è un libro che forse attendevo da oltre quarant’anni. Perché unisce al sommo piacere di rileggere 219 citazioni di effervescenti e travolgenti passi-passaggi e periodi dell’autore del Pasticciaccio, la connessa e assai dotta loro esplicazione filologica, etimologica e semiologica. Secondo sottolinea Italia: «… a leggere Gadda ci si diverte moltissimo. A volte si ride irrefrenabilmente, fino alle lacrime… Oppure il registro trasvola al lirico, mostrando come, fino agli anni Cinquanta, la prosa del Novecento, non solo la poesia, aveva salato il proprio sangue nella “tradizione del Novecento”: Carducci, Pascoli, d’Annunzio… la tensione tra i due poli, satirico e lirico, basso e alto, non deve stupire. Il plurilinguismo, che Dante per primo aveva praticato… è anche pluristilismo, e uno dei meccanismi della satira è la divaricazione stilistica (stile alto per contenuto basso e viceversa)…».
Insomma, chi vuole e chi può celebri il cinquantenario della dipartita di Carlo Emilio, leggendo avidamente, come ho fatto io, il Gaddabolario.
Che mi ha talmente deliziato da spingermi alla composizione di un simil-sonetto persin caudato, tutto intramato con le parole del Gaddus (sperando che non se ne abbia a male):
“In gaddianese”
Gelativendolo, compossibile, tergiversante
Pispillorio, stramontano, eredoluetico
Lollobrigido, detopaziato, abracadabrante
Gorgonzoloide, ludro, scaricabaristilistico
Predappiofezzo, masocone, ingravallesco
Barbivelluto, piscivùlvulo, cinobàlanico
Gruzzolante, pirobutirro, ebefrenico
Barbuglioso, eupeptico, calamburesco
Rachitoide, faraonide, basedowizzato
Dottoronzolo, croconsuelo, sperlusciato
Preposturale, psicopompo, strugnoccolo
Pedagoghesco, velocipedastro, celicolo
Flautante, digito-interrogativo, polluto
Voronoffiano, spighereccio, fronzuto
Anni belli ► A Piazza Verbano a Roma, nel quartiere Trieste-Salario, vi era una sala cinematografica omonima che una trentina di anni fa mutò il nome in Cinema Admiral. Cinema monosala che ha resistito orgogliosamente e gagliardamente all’assalto delle multisale, nonché al progressivo diradarsi degli spettatori cinematografici sino al marzo del 2020. L’arrivo del covid, il drastico lockdown nazionale decretato dall’allora governo Conte che chiudeva tutti i luoghi di incontro e di svago collettivo, sono stati però un colpo mortale per l’Admiral. Dopo la fine dell’emergenza il cinema di Piazza Verbano non ha più riaperto i battenti. Verosimilmente anche a causa della bancarotta del gruppo del produttore Massimo Ferrero, “er viperetta”, nel cui circuito di sale l’Admiral era incluso.

L’ultimo film in programmazione è stato Gli anni più belli di Gabriele Muccino, e l’insegna di questa pellicola è rimasta in questi tre anni e mezzo a sovrastare l’ingresso della sala sigillata, non smontata da nessuno. Un’insegna beffarda o, se si vuole, psico-simbolica che può alludere a tante cose. Agli anni belli dell’Admiral come dignitoso cinema di quartiere in cui si incontravano tante persone che, almeno di vista, si conoscevano e ri-conoscevano. Agli anni belli della frequentazione delle sale cinematografiche – io pure vado oggi assai di meno al cinema e, quando ci vado, vedo platee desolatamente vuote o semivuote –, laddove soprattutto i più giovani fruiscono i film in distribuzione sulle piattaforme e li guardano sul display del telefonino. Agli anni belli, forse pure, del tempo pre-covid, trauma pandemico collettivo che forse non abbiamo ancora del tutto elaborato e metabolizzato, anche se nel corso dei secoli le epidemie di peste ed altro ci sono sempre state, facendo anche molte più vittime del coronavirus, e non risulta che questo abbia minimamente migliorato l’indole degli uomini e il loro approccio basico alla vita. Si potrebbe pure pensare che gli anni belli probabilmente ci sono sempre o non ci sono mai, che ci barcameniamo costantemente tra aspirazioni sublimi, generose utopie, radiose speranze e un’esistenza di merda. L’Admiral sprangato, il suo spazio commercialmente non più appetito da alcuno, e la sua surreale insegna mi sembra allora che ci facciano da specchio, forse un ironico ‘memento mori’, rammentando anche Rainer Maria Rilke che nelle Elegie duinesi scrive: “Poiché il bello / è solo l’inizio del terribile, che ancora noi sopportiamo, / e lo ammiriamo così, ché quieto disdegna / di annientarci. Ogni angelo è tremendo”.
Cinerealismo e no ► All’ultimo Festival di Cannes nella sezione “Un certain regard” è stato proiettato il film Los delinquentes del regista e sceneggiatore argentino Rodrigo Moreno. Un tipo che ostenta di andare controcorrente e dice di sé: “Sono un cineasta cinefilo, ma non cerebrale… Gli ultimi film li ho realizzati da solo, con una piccolissima troupe. Volevo rivendicare anche questo: un cinema fatto a mano, liberatorio”. Durante la conferenza stampa Moreno si è poi lanciato in un affondo polemico: “… io credo che la vera posizione politica del film sia nella sua forma, oggi c’è un totale dominio del realismo come forma di rappresentazione, una completa rinuncia al linguaggio cinematografico che è diventato invertebrato, senza verbo. Per me il male non è iniziato con Netflix, ma prima, con i fratelli Dardenne e la loro scelta di girare con la macchina intorno ai propri personaggi dimenticando gli elementi fondamentali del cinema: dissolvenza, taglio, split screen, musica… Non voglio attaccare loro personalmente, sono pensionati belgi, gente per bene, ma il problema sono le conseguenze di tutto ciò”.

Rodrigo Moreno
Si potrebbe pure convenire con Moreno, salvo l’inelegante e sprezzante epiteto, “pensionati belgi”, riservato agli ottimi fratelli Dardenne che, del resto, potrebbero replicare che ciascuno fa il cinema che sa e che può fare, e che se l’ipotetico, eventuale modello realista dei loro film influenza tanti altri registi, non è certo per loro precipua volontà o efferato desiderio di egemonia estetica.
In ogni caso, è vero che la forma realista domina il mercato (soprattutto in Italia) e che basta una pellicola che infranga quel codice – penso a Lo chiamavano Jeeg Robot (2016) di Gabriele Mainetti – e subito si inneggia al miracolo o alla straordinaria novità (che così evidentemente non è, sin dai tempi preistorici di Georges Méliès). Per trovare, quindi, nuovi permanenti scatti di fantasia antirealista dovremo aspettare che i film li faccia la Artificial Intelligence?
La verità dei numeri ► Lo statistico e demografo Roberto Volpi ha firmato un interessante libro, In quel tempo. Da Gesù a Paolo attraverso i numeri del Nuovo Testamento (Solferino, 2023), da cui si apprende che in Galilea, al tempo in cui il Nazareno diffondeva la sua ‘buona novella’, l’età media degli abitanti era molto bassa. In pratica, uno su tre aveva meno di quattordici anni, la più parte della popolazione oscillava tra i quindici e i trentacinque anni, la durata media dell’esistenza non superava i venticinque. Coloro che raggiungevano i cinquant’anni et ultra erano assai rari. Ecco allora che la narrazione tradizionale, religioso-folklorica su Jesus cambia radicalmente tenore. Si è sempre visto il Nazareno, crocefisso a trentatre anni, come un uomo ancora giovane, ritratto dalla plurisecolare oleografia pittorica secondo un beatnik avanti lettera, un capellone barbuto, predicatore ribelle a capo di una piccola comunità nomade, una icona già bell’e pronta per filmoni musicali celebrativi come Jesus Christ Superstar. E invece il nostro ‘unto del signore’ per i parametri anagrafici della sua epoca, era in sostanza un anziano, forse una sorta di saggio eterodosso che si era messo tardi in cammino verso la rivelazione della ‘vera fede’.
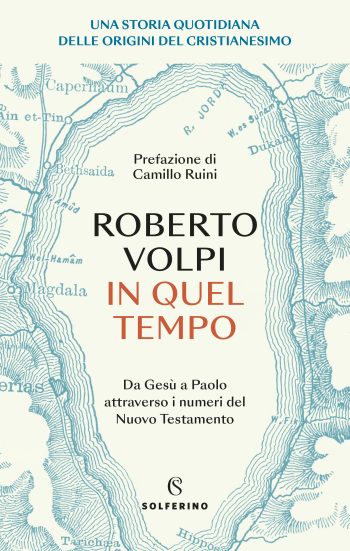
Insomma, ci sarebbe da revisionare tutto il nostro presente sguardo sul Cristo filtrato dai Vangeli sinottici. Uno sguardo più apocrifo dei Vangeli apocrifi. E verrebbe, allora, da chiedersi che età avesse la madre Maria che probabilmente lo aveva partorito a non più di tredici-quattordici anni. Quando Jesus fu ucciso lei avrebbe, dunque, dovuto avere quarantasei o quarantasette anni, un’età da vegliarda, sempre per i parametri del tempo. Sono domande, suppongo, che rimarranno inevase. In ogni caso, se i numeri statistici di Volpi non ci diranno la verità o tutta la verità, sicuramente contribuiscono a sfatare narrazioni false e consolidate leggende. Che si creda o non si creda bisogna fare i conti e farci i conti… augh.
Persistenza dell’antifascismo ► Da quando si è insediato il governo Meloni, sono assai frequenti da parte dei ‘fratellini d’Italia’ e dei loro rappresentanti mediatici le lamentazioni contro le giaculatorie degli antifascisti e contro i ricorrenti allarmi di possibili rigurgiti fascisti. Epperò se si legge la riedizione (Oscar Mondadori) del libro di uno di loro, l’attuale ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (già direttore del Tg2), si possono ben comprendere i motivi di tale ‘vigilanza antifascista’. Nel volume in questione, Giuseppe Prezzolini. L’anarchico conservatore, una esaustiva biografia del giornalista e scrittore perugino, si riporta la sua riflessione nel dopoguerra a proposito del regime mussoliniano. Prezzolini sottolinea come per oltre vent’anni il fascismo abbia avuto il consenso della stragrande maggioranza del popolo italico. Aggiungendo che, se non si fosse impelagato nella disastrosa guerra, esso sarebbe verosimilmente sopravvissuto a lungo col sostegno e il plauso dei più. Prezzolini, si badi, era un liberal-conservatore, non aveva aderito al fascismo, era andato esule in America, insegnando a New York e prendendo poi nel 1948 la cittadinanza Usa. Però il medesimo Prezzolini di tanto in tanto rientrava in Italia per soggiorni di vacanza o di studio e non si peritava di avere colloqui sia con il Duce, che aveva conosciuto sin dai tempi in cui dirigeva la rivista “La Voce”, sia con il filosofo Benedetto Croce. E questo mostra tutta l’ambiguità politico-culturale di quell’epoca: per cui l’anarco-conservatore a-fascista colloquiava tranquillamente sia con il capo del fascismo, sia con il maggiore pensatore italiano, critico sì del regime, ma in una postazione defilata, di opposizione non attiva. L’essenza del blocco della destra in Italia sta proprio in questa torbida, opaca, equivoca collateralità tra fascismo e a-fascismo.
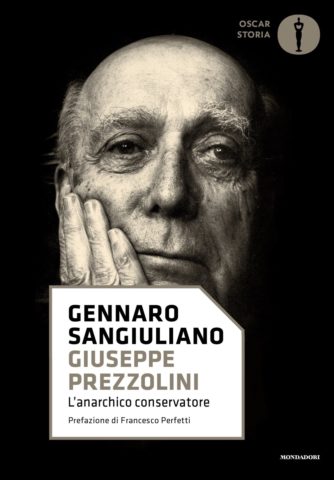
Il problema è che la narrazione antifascista dominante ha fatto passare la versione di tutto o quasi tutto un popolo italico che insorse contro la dittatura mussoliniana. Una narrazione rassicurante, ma che semplicemente non è vera. La Resistenza fu opera di una avanguardia, di una minoranza attiva. Tra il ’43 e il ’45 si combattè un’aspra guerra civile, che senza le truppe d’invasione anglo-americane non si sarebbe mai conclusa con la vittoria del fronte antifascista. La pacificazione, probabilmente necessaria, del dopoguerra culminò, poi, nel giugno 1946 con il decreto di amnistia firmato da Palmiro Togliatti, allora ministro di Grazia e Giustizia, che liberò migliaia di fascisti, tra cui stretti collaboratori del Duce, fucilatori di partigiani come il principe Junio Valerio Borghese e autentici criminali di guerra (penso soltanto al Maresciallo Rodolfo Graziani, reiterato carnefice di libici ed etiopi). Così, nel dicembre di quello stesso anno, i fascisti ebbero a riorganizzarsi e a fondare l’MSI (Movimento Sociale Italiano), sigla che richiama ovviamente la RSI (Repubblica Sociale Italiana) sottomessa al nazismo, ma è pure il criptico acronimo di “Mussolini Sempre Impera”. Questo per fare intendere la perfetta continuità tra fascismo e postfascismo. Più e più volte rivendicata, peraltro, dal lider maximo missino Giorgio Almirante.
Per non parlare del tempo della ‘guerra fredda’ in cui gruppi fascisti sono stati ripetutamente usati come manovalanza terroristica nell’ambito di una strategia anticomunista Nato-atlantica propugnata da un intrico di servizi segreti, Cia e agenzie militari senza nome.
Ciò per dire che il ritorno del fascismo non è certo adesso all’ordine del giorno, ma c’è un filo nero che si snoda lungo tutta la storia della Repubblica italiana nata dalla Resistenza e che si rispecchia pure in un sentimento non esplicitamente antifascista di una parte cospicua, forse preponderante della popolazione italica. È il ‘fronte grigio’ di cui parlava lo storico Renzo De Felice, quella massa indifferente, se non indulgente, sostanzialmente passiva, agnostica, che è né pro né contro il fascismo. È questa massa grigia, con la sua amorfa conformazione politica o impolitica che dir piaccia, a rappresentare il pericolo maggiore, perché sempre potenzialmente disponibile a dare il suo consenso ad avventure reazionarie, autoritarie o di ‘uomini soli al comando’. È questo che giustifica il permanente richiamo antifascista, pur se posso comprendere il fastidio per la retorica istituzionale continuamente alimentata da un sepolcro imbiancato veterodemocristiano quale il presidente Mattarella.
Un nome ► Morti senza nome e morti con un nome. E il nome fa la differenza, fa una grande differenza. Penso al centinaio di bambini morti nel naufragio, a metà giugno, di un peschereccio libico stracolmo di emigranti vicino alle coste della Grecia; penso ai tanti, innumeri bambini morti in Ucraina per le bombe, le cannonate, le rappresaglie varie degli invasori russi. Bambini vittime anonime, senza volto, senza identità, a cui si rivolge un pensiero fuggevole, uguale a quello espresso, secoli fa, con spietata sincerità dalla illustre scrittrice britannica Jane Austen (1775-1817): “Che pena per tutte quelle migliaia di poveretti morti in guerra, ma che sollievo che non ci importi nulla di loro”.
Di contro penso alla morte di Manuel Proietti, cinque anni, deceduto a seguito dell’incidente, avvenuto a Roma, a Casal Palocco, in cui una Lamborghini Urus si è schiantata alla velocità di 124 km orari contro la Smart “FourFour” guidata dalla madre del piccolo. Incidente assurdo, pressoché criminale, laddove a bordo della Lamborghini c’era un gruppo di ‘youtuber’ ventenni, denominato “TheBorderline”, impegnato in una ‘challenge’, una sfida che consisteva nel rimanere per cinquanta ore consecutive a bordo dell’auto, filmando il tutto. Sfida pazzescamente idiota, oltretutto, è stato poi svelato, farlocca, perché i prodi youtuber falsificavano il montaggio del video comprovante la ‘challenge’, che comunque procurava loro migliaia di followers, nonché l’entrata di decine di migliaia di euro. Perché oggi, grazie ai social, l’imbecillità iperbolica è un lucroso business.
Resta di tutto questo l’ondata di cordoglio e sincera commozione nazionale per il bambino Manuel Proietti, innocente vittima della stupidità assassina dei ragazzi ‘borderliners’. Resta il suo nome nella nostra memoria, ciò che fa, ripeto, una grande differenza perché, almeno per un attimo, ci siamo identificati tutti nello strazio di una madre e di un padre che hanno perso senza motivo il loro figlioletto; sì, ci è importato di Manuel Proietti. Un nome che cercheremo di non dimenticare, anche come ‘ersatz’ per tutti gli altri bimbi finiti, senza nome, nell’imbuto della smemoria.
Giugno 2023