di Marco Palladini
Quando ebbi a leggere in rete della prossima uscita del nuovo libro di Attilio Scarpellini Figlio di cane (Mimesis, 2024), conoscendo Attilio come autorevole critico di teatro e raffinato saggista, pensai ovviamente a un testo saggistico. Invece Scarpellini mi comunicò che non di un saggio si trattava, bensì di una drammaturgia. La cosa implementò la mia curiosità, dal momento che in questo paese assai raramente la drammaturgia scritta trova uno sbocco editoriale.
Letto rapidamente il libro mi sono però insorte varie perplessità e mi sento di consentire col prefatore Andrea Cortellessa quando afferma: “In un certo senso, Figlio di cane si può considerare un esperimento di deformazione parossistica, e quasi teratologica, della forma-saggio in una certa sua declinazione moderna (o piuttosto post-): dove la biografia dell’autore si sovrappone alla forma dei suoi testi, così producendo ibridi indiscernibili, tanto suggestivi quanto sottilmente mostruosi”.
Un testo ‘monstrum’, dunque, un testo ibrido sin dalle sue premesse che Scarpellini ha voluto poi dimensionare in una forma drammaturgica, per quanto assai straniata.
La scaturigine biografica del lavoro prende le mosse da un casuale incontro a Parigi, il 18 febbraio 1979, quando Attilio, credo meno che 23enne, assieme ad altre tre persone poi mai più riviste, viene approcciato da un personaggio dall’aspetto barbonesco, ma insieme carismatico e seducente che si aggirava per il caffè Bonaparte a Saint Germain-de-Prés. Quest’uomo, allora 49enne, è un ebreo russo, nato però a Praga, che si era rifugiato in Francia nel 1958. Il suo nome è Vladimir Slepian, ma Scarpellini per circa quarant’anni ha continuato a pensare che fosse un emigrato armeno e si chiamasse Viktor Sclepian. Questo Slepian era fondamentalmente un pittore che, come sottolinea nella postfazione François Grosso, ripudiato il realismo socialista si disbrigava tra Action Painting, happening e performance, sino a teorizzare negli anni Sessanta “un’arte transfinita”. Slepian a un certo punto smise di dipingere e pubblicò sulla rivista “Minuit” un racconto intitolato Fils de chien. Il quale racconto attirò l’attenzione di Gilles Deleuze e Félix Guattari, i quali nella loro summa filosofica Mille piani (1980) gli dedicarono una fervida disamina critica nel capitolo imperniato sul “divenire-animale”. Ora tutta questa premessa romanzesca trova un punto di svolta nel 2015 quando le éditions du Chemin de fer pubblicano per la prima volta in volume Fils de chien (mentre intanto Slepian è morto nel luglio 1998). Ed è da questa ripubblicazione e riscoperta di nove anni fa che prende l’aire Scarpellini che riannoda i fili della sua memoria giovanile ed imperfetta e del fascino che emana da un personaggio singolare, eminentemente irregolare e intellettualmente sulfureo come Slepian per immaginare un intreccio drammatugico in cui si incontrano su una panchina di legno in una piazza parigina, mentre incomincia a nevicare, due figure: il predetto VS, vestito con un abito color carta da zucchero e una camicia bianca e “non ha un’età determinata”, cioè potrebbe tranquillamente essere il fantasma o l’avatar dell’emigrato russo; l’altro è AS, patente alter-ego di Attilio, ha un’età tra i 50 e i 60 anni, “è vestito come un intellettuale di sinistra, ma di scarsa fortuna”.
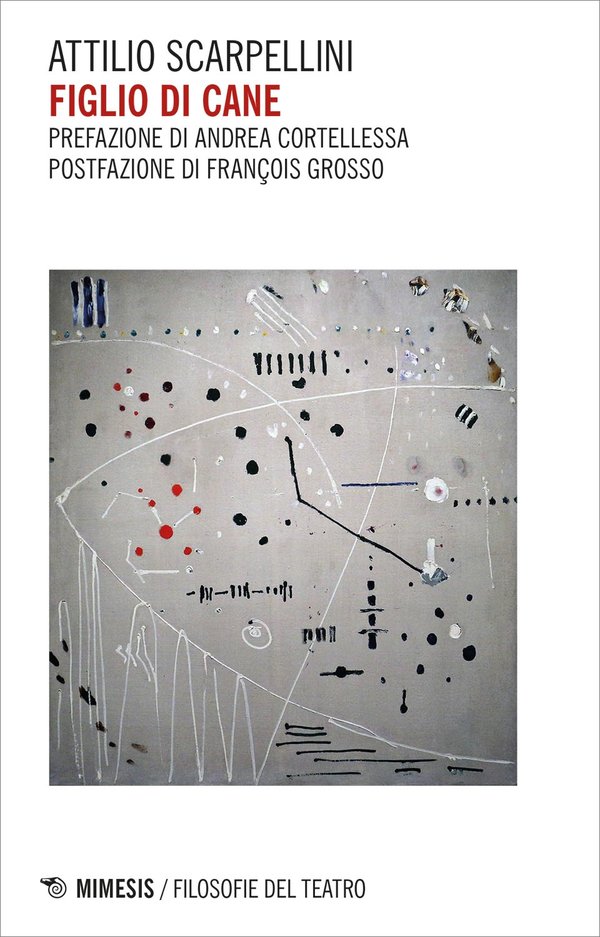
La sostanza teriomorfe di Figlio di cane si dispone su un doppio binario dialettico, ma a-dialogico, in cui Scarpellini sussume il titolo e il testo originale di Fils de chien, frammentandolo e remixandolo e facendone la materia verbale delle battute pronunciate da VS; laddove invece AS procede in una sorta di anamnesi critica dell’incontro originario del 1979, procedendo ad un confronto tra il passato e il presente, a partire da quei giorni in cui avendo la Cina oltrepassato i confini del Vietnam si paventava uno scontro con l’Unione Sovietica e, forse, persino una Terza guerra mondiale (come pure oggi, peraltro, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia putiniana), per seguire con il ricordo spicciolo che il maneggione Slepian gli avrebbe rubato una banconota da 500 franchi, ma forse trattasi di un ricordo vago e non veritiero. L’architettura intellettuale, para-saggistica del testo mi è sembrata abile, ben calibrata, anche sfiziosa, teatralmente però le due voci giustapposte non danno luogo a una reale e risolutiva dinamica drammatico-narrativa. Le elucubrazioni para-etologiche e para-filosofiche del dropout VS sul suo caparbio immaginare di trasformarsi in un cane fanno pensare ai drammi ‘statici’ (per dirla con Pessoa) del teatro dell’Assurdo e, ovviamente, a Beckett (che, tra l’altro, sembra avesse aiutato economicamente Slepian, privo di fonti di reddito sicure); le manipolazioni e interpolazioni tra figure reali e immaginarie rimandano naturalmente a Borges. Ma un altro nome, leggendo Figlio di cane, mi è venuto in mente, quello di Roberto Bolaño, capace come pochi di intrecciare autobiografia e personaggi erratici e selvaggi, attraverso seducenti racconti mitopoietici.
Sul finale scatta, probabilmente, l’autentico ‘punctum’ di questo testo ibrido. Quando AS asserisce: “… a un certo punto mi aveva detto: noi due ci assomigliamo, non trova? (…) Gli avrei voluto rispondere, sì, l’ho pensato anche io, che in qualcosa ci assomigliamo. Ma tu sei un pazzo e i pazzi mi fanno paura, forse perché ho io stesso paura di impazzire, perciò, anche se qualcosa che non riesco a definire, come una somiglianza, mi tiene avvinto a te, l’ultima cosa che desidero è assomigliarti (…)”.
Ecco, credo che sia in questo groviglio oscuro di attrazione/repulsione la matrice prima e il senso e l’urgenza che Scarpellini ha avuto di scrivere/riscrivere Figlio di cane. Così, la trasvalutazione della riflessione critica in un teatro del perturbante è forse, in primis, per lui, un atto esorcistico, uno sfuggire alla via della follia in cui si chiunque di noi può rischiare di inoltrarsi.